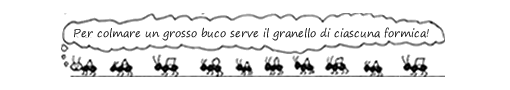- Dettagli
-
Creato: Sabato, 14 Ottobre 2023 00:00
-
Scritto da Rocco Artifoni
Il programma elettorale della coalizione di destra-centro era chiaro: introdurre la flat tax per tutti i contribuenti.
Ma fin dall’insediamento del nuovo esecutivo è sembrato un obiettivo arduo al punto tale che, alla prima occasione, la premier Meloni aveva chiarito che la tassa piatta per tutti resta l’obiettivo (sempre che si riesca a bypassare i rilievi di incostituzionalità già evidenziati da molti), ma con l’orizzonte di fine legislatura.
L’approvazione a inizio agosto della legge delega per la riforma fiscale ha messo nero su bianco la progressiva transizione dal modello di imposizione a scaglioni sui redditi delle persone fisiche alla tassa piatta unica. Ora il Governo si appresta al primo step, ovvero accorpare i primi due scaglioni IRPEF, attualmente con aliquote del 23% (fino a 15.000 euro) e del 25% (da 15.000 a 28.000 euro), con un’unica aliquota al 23%. Il provvedimento sarà inserito nella legge di Bilancio del 2024, che verrà varata lunedì prossimo dal Consiglio dei Ministri.
Questa riduzione delle imposte a prima vista sembrerebbe a favore del ceto medio, cioè di chi ha un reddito tra 15.000 e 28.000 euro, che avrà un 2% di riduzione dell’aliquota. In realtà, il sistema a scaglioni prevede che lo sconto fiscale si applichi pienamente soltanto ai contribuenti con redditi superiori ai 28.000 euro. Pertanto, la diminuzione delle imposte di fatto sarà questa: 260 euro per chi ha redditi superiori a 28.000 euro, uno sconto decrescente da 260 a zero euro per redditi da 28.000 a 15.000 euro e nessun risparmio per redditi inferiori a 15.000 euro.
Dai numeri effettivi emerge chiaramente che si tratta di una riforma fiscale disegnata a favore dei più abbienti e di conseguenza contro i più poveri. Infatti, più basso è il reddito e minore sarà il beneficio fiscale, che si azzera per i redditi più bassi.
Non solo: le minori entrate dovute alla diminuzione dell’aliquota di 2 punti (circa 4 miliardi di euro), comporteranno minori risorse disponibili per finanziare le spese sociali, cioè proprio quelle che costituiscono un sostegno alle persone più in difficoltà economica.
Ad aggravare la situazione è l’insieme della manovra economica che il Governo sta predisponendo.
Si tratta in totale di 22 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi in deficit. In questo modo si continua ad aumentare il debito pubblico, pur sapendo che è già il più alto d’Europa (circa il 140% nel rapporto debito/PIL). Di conseguenza aumenteranno gli interessi sul debito, per altro già in aumento per il rialzo dei tassi.
È evidente che il Governo sta spendendo soldi che in realtà non ha. Il conto sarà caricato ancora una volta sulle spalle delle prossime generazioni. Per questa ragione lo sconto fiscale per i più ricchi attraverso l’accorpamento delle prime due aliquote IRPEF non ha alcun senso.
È soltanto un tentativo di mostrare agli elettori di aver realizzato almeno una piccola parte delle troppe promesse fatte. E anche questa è propaganda.
Fonte: http://www.liberainformazione.org/2023/10/13/fisco-uno-sconto-per-i-piu-ricchi/
- Dettagli
-
Creato: Giovedì, 07 Settembre 2023 00:00
-
Scritto da --
È quello del Giappone, che è grande più di due volte e mezzo il suo PIL: finora non è mai stato un problema.
Il Giappone ha il debito pubblico più alto del mondo, pari al 258 per cento del suo Prodotto Interno Lordo. È il risultato di una serie di politiche che i governi degli ultimi 30 anni hanno messo in atto per stimolare un’economia asfittica e che non cresce.
È però un debito pubblico che non ha mai suscitato grandi preoccupazioni da parte degli investitori internazionali, grazie a particolari caratteristiche dell’economia giapponese, come il fatto che il debito sia detenuto in gran parte dalla banca centrale e da investitori locali, che lo stato possegga un patrimonio consistente a garanzia e che la spesa pensionistica sia sotto controllo nonostante la popolazione che invecchia. È comunque diventato un caso di scuola di come anche un debito molto alto possa essere sostenibile, tant’è che spesso in Italia molti politici, analisti e commentatori lo usano come esempio del fatto che un debito pubblico alto non sia tutto sommato un problema. Ma ci vogliono comunque molte cautele nel provare ad adattare il modello giapponese all’Italia, il cui debito pubblico corrisponde al 144,4 per cento del PIL.
È vero che l’economia giapponese per molti versi è simile a quella italiana: ha il debito pubblico più alto al mondo (quello italiano è il quinto per dimensione) e negli ultimi 25 anni, insieme a Grecia e Italia, è tra i tre paesi avanzati con il più basso tasso di crescita del reddito pro capite.
Le cause della bassa crescita economica in Giappone sono strutturali e molto legate alle caratteristiche della società giapponese: la popolazione è piuttosto invecchiata e questo ha comportato una riduzione della forza lavoro, con pessime conseguenze in termini di innovazione e produttività, i due ingredienti principali della crescita.
Per questo da molti anni i governi e la banca centrale giapponese cercano di stimolare l’economia. I governi stanno cercando di farlo con riforme strutturali, sussidi e incentivi che hanno alimentato il debito pubblico; la banca centrale invece garantendo ampia liquidità all’economia e mantenendo artificialmente bassi i tassi di interesse, ossia il prezzo a cui le banche prestano il denaro. Bassi tassi di interesse invogliano a prendere a prestito denaro per comprare cose o investire, ma hanno poi reso molto facile indebitarsi per lo stato.
Per anni in Giappone i prezzi non sono cresciuti, e in certi periodi sono addirittura diminuiti: in questo caso si parla di deflazione, ossia di una riduzione generale del livello dei prezzi che caratterizza un’economia ferma, che non cresce e in cui la domanda è troppo debole. Negli ultimi vent’anni, di fatto, le autorità economiche e monetarie hanno cercato attivamente di creare inflazione nel paese, perché prezzi in aumento avrebbero rappresentato un segnale che l’economia aveva ripreso a crescere.
Fino a un paio d’anni fa, questa politica di stimolo dell’economia giapponese era stata più o meno allineata a quelle dei paesi occidentali, anche se con certe differenze e con molta più cautela da parte dell’Occidente. Anche negli Stati Uniti e in Europa, fino a un paio di anni fa, i tassi d’interesse erano eccezionalmente bassi, e i governi attuavano politiche di stimolo.
Poi le cose hanno cominciato a cambiare e da un anno in tutte le economie avanzate le banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse per combattere l’inflazione, ma il Giappone sta facendo le cose un po’ al contrario: continua a tenere i tassi bassi cercando di far crescere l’economia, non curandosi dell’inflazione che pure ha colpito l’economia. L’inflazione giapponese è pari al 3,3 per cento, più bassa rispetto al resto delle economie avanzate, con l’eccezione degli Stati Uniti: per la prima volta da 8 anni a giugno l’inflazione giapponese ha leggermente superato quella statunitense, anche se solo di qualche decimale.
Secondo molti, un altro motivo per cui il Giappone non aumenta i tassi di interesse è proprio il debito pubblico: molti ritengono che il rialzo dei tassi contribuirà a rendere il debito pubblico insostenibile. Gli analisti sono concordi nel dire che prima o poi il Giappone dovrà trovare il modo di agganciarsi e adeguarsi alle politiche occidentali. Ma anche l’ipotesi di aumento dei tassi di interesse non disturba e non preoccupa particolarmente gli investitori internazionali.
I motivi per cui il debito pubblico giapponese è giudicato così sostenibile sono vari. Il primo è quello più immediato: il Giappone ha una sua valuta e il debito pubblico è detenuto in gran parte dalla banca centrale. La banca centrale giapponese non diventerà mai un creditore ostile al paese e il debito giapponese non è esposto a fluttuazioni della valuta estranee alla sua economia, proprio perché espresso in yen.
Un altro motivo è che i conti pubblici del Giappone non sono così messi male come potrebbe far pensare un debito così alto: con l’eccezione degli anni della pandemia, da tempo il deficit di bilancio è in calo. Il deficit è la differenza tra le entrate dello stato, ossia le tasse, e le spese, come gli stipendi pubblici, le pensioni, la spesa sanitaria e così via: se è positivo le entrate sono maggiori delle uscite e si crea così un avanzo di bilancio; se è negativo se le spese superano le entrate e così lo stato deve finanziarsi con il debito, che via via si accumula. Negli anni il governo giapponese ha cercato di provare a contenere il deficit, ossia l’accumulazione di debito pubblico.
In più, lo stato giapponese ha un patrimonio notevole: secondo i calcoli dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani possiede attività non finanziarie, come immobili, per un valore che va oltre il 100 per cento del PIL e titoli finanziari per il 112 per cento del PIL. Per fare un paragone, quello italiano detiene attività non finanziarie per un ammontare pari a solo il 52 per cento del PIL e quelle finanziarie per il 28 per cento del PIL. Il patrimonio è il principale strumento a disposizione dei creditori in caso le cose dovessero mettersi male: lo stato può vendere immobili o titoli finanziari per ripagare il suo debito. Il Giappone ha un patrimonio quasi pari all’intero debito pubblico: per assurdo, potrebbe venderne una parte e dimezzare il debito in brevissimo tempo, se volesse.
Un altro punto a favore della sostenibilità della finanza pubblica giapponese riguarda la spesa per le pensioni, che è fonte di possibili preoccupazioni soprattutto in caso di un paese che invecchia sempre di più: grazie a una serie di riforme strutturali con cui è stata aumentata l’età pensionabile (si va in pensione intorno ai 70 anni), il Giappone ha una spesa pensionistica tutto sommato contenuta e giudicata sostenibile, nonostante la popolazione con un’aspettativa di vita sempre maggiore e in crescente invecchiamento. E questo è un motivo di preoccupazione in meno per la sostenibilità futura del debito.
Tutte queste particolarità insieme rendono il debito pubblico giapponese tutto sommato sicuro, nonostante l’enorme valore. È improprio parlare di un modello giapponese, soprattutto nel caso in cui si tenti di applicarlo a economie con caratteristiche diverse.
Spesso in Italia se ne parla in termini di modello virtuoso a cui rifarsi: ma le finanze pubbliche italiane negli anni hanno avuto una gestione molto meno prudente di quelle giapponesi, il sistema pensionistico è molto costoso e per motivi quasi sempre politici è sempre più difficile cercare di renderlo meno oneroso per le future generazioni.
Un altro tema spesso toccato dagli ambienti più scettici nei confronti del funzionamento del sistema dell’euro riguarda il ruolo che la banca centrale ha in Giappone: nei decenni ha finanziato il debito pubblico del paese e il fatto che oggi ne detenga una buona parte lo rende tutto sommato sicuro e non un fattore di possibile squilibrio finanziario.
Questo in Italia e nei paesi che adottano l’euro non può avvenire perché è vietato dalle regole sul funzionamento della moneta unica: la Banca Centrale Europea non può finanziare direttamente il debito degli stati ed è indipendente dalle loro scelte politiche e di spesa pubblica, in modo da non alimentare un meccanismo di sottomissione della politica monetaria alle esigenze dei conti pubblici. Quando questa sottomissione viene percepita come rilevante, i rischi per la stabilità finanziaria e la credibilità di un paese sono molto elevati.
Il Giappone finora non ha mai vissuto una crisi di fiducia da parte degli investitori, come per esempio è capitato all’Italia durante la crisi dei debiti sovrani che ha colpito molti paesi europei nel 2011 e nel 2012, perché la banca centrale giapponese era sempre pronta a intervenire per salvaguardare la stabilità. Ma anche perché in termini di gestione dei conti pubblici il Giappone nei decenni si è rivelato prudente, cosa che invece i governi italiani non sempre sono riusciti a fare.
Fonte: https://www.ilpost.it/2023/09/03/debito-pubblico-giappone/