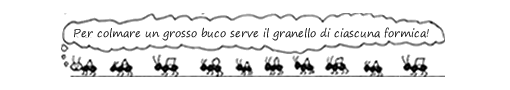Aiuti una tantum, spesa esagerata
- Dettagli
- Creato: Mercoledì, 11 Maggio 2022 00:00
- Scritto da Beppe Facchetti

I 14 miliardi stanziati per aiuti e provvidenze varie hanno spiazzato un pò tutti, sindacati e Confindustria compresi, che preferiscono soluzioni strutturali sul cuneo fiscale (16 miliardi, ma per sempre) e non la politica degli una tantum. La copertura viene da una supertassa del 25% sugli «extraprofitti» delle società energetiche e, in un Paese che non ama i profitti, figuriamoci gli extra, la cosa non ha fatto scalpore, anche se - in mancanza di una politica europea dei prezzi - una parte di questi guadagni viene da precedenti, prudenti scelte di approvvigionamento, e anche se lo Stato-azionista vedrà meno dividendi.
Certamente positivo è il fatto che si sia evitato un nuovo «scostamento di bilancio», formula magica ultimamente sempre più evocata, una specie di abracadabra da dichiarazione serale ai Tg, molto gettonata da chi solo promette. Ipocrisie semantiche che sarebbe meglio chiamare con il loro nome: nuovo debito da scaricare su figli e nipoti, perché questo e non altro sono gli «scostamenti».
Ma guerra e costi energetici appesantiscono segnali già chiari di una svolta necessaria. Non poteva durare l’era felice dell’inflazione zero, dei micro interessi, dei miliardi elargiti da Bruxelles e Francoforte persino per i costi di parte corrente. Oggi l’inflazione viaggia sopra il 6% e la BCE non tarderà a chiudere i rubinetti monetari. Lo stesso Recovery europeo è in gran parte debito, peraltro condizionato a riforme politicamente pesanti, con impegni conseguenti che scricchiolano da tutte le parti e persino i magistrati scioperano per una piccola riforma. Le vecchie abitudini (rinviare, edulcorare, manzonianamente sopire) non reggono più. Si poteva far finta prima, sotto l’ombrello della più straordinaria bonaccia dell’economia mondiale (globalizzazione, multilateralismo e liberalizzazioni, piaccia o non piaccia), che pure aveva propiziato il populismo, male delle democrazie intorpidite.
Ma ora tutto è rivoltato. Con il lockdown, a salvarsi erano stati alcuni in fondo alla scala, come pensionati e dipendenti pubblici, perché a reddito garantito, ma ora proprio loro sono il bersaglio dell’inflazione. Le categorie legate alla mobilità, dall’auto al turismo, al tempo libero sono state triturate dalle montagne russe: prima azzeramento e poi ripresa violenta ma forse precaria. Ha prosperato il colosso Amazon, hanno chiuso i bar. I grattacieli degli uffici sono diventati monumenti inutili, svuotati dallo smart working. Quanto alla guerra, ha messo a nudo il narcisismo delle politiche energetiche tutta virtù rinnovabile e sta punendo gli imprenditori coraggiosi dell’export, ma anche le miopie egoiste della delocalizzazione selvaggia. La graduatoria dei ricchi e degli impoveriti, dei meritevoli e degli incolpevoli ci restituirà alla fine gerarchie dei problemi impensate. Nulla sarà più come prima.
Sui conti pubblici, intanto, si sommano due scostamenti veri: quelli dell’ultima stagione spensierata del populismo e quelli dell’emergenza, dei ristori e dei bonus, fino appunto ai 200 euro una tantum. Quando si faranno i conti finali, le cifre saranno gigantesche. Avrebbero potuto ribaltare l’economia e la società, se spese bene. Hanno tappato buchi. Miliardi che hanno reso poca cosa persino la propaganda del reddito di cittadinanza e di quota 100, o i costi del non fare per i blocchi a TAP, trivelle, TAV e via dicendo, anche se il no è un vizio inestirpabile: ora tocca al termo-valorizzatore di Roma, nonostante gabbiani e cinghiali non siano la soluzione. Siamo in un anno pre-elettorale, il meno adatto per mettere a posto le cose, e partiti e coalizioni non godono di buona salute: centrodestra spaccato, M5S in agonia, PD isolato, arcipelago centrista malato di personalismo. Ma forse si sta percependo che la ricreazione è finita. In Francia e Slovenia, l’emotività di certi temi come l’immigrazione non ha funzionato più e si è badato al sodo: Europa e tenuta del potere d’acquisto. Da noi devono ancora riemergere temi veri come pensioni, lavoro, e fisco, ma in termini complessivi, non a tratti. Tutti keynesiani a parole, ma attenti, perché Peron è sempre dietro l’angolo.
Fonte: https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Editoriale/aiuti-una-tantum-spesa-esagerata_1429213_11/